
CARLO WOSTRY
STORIA DEL CIRCOLO ARTISTICO
DI TRIESTE

LA NASCITA DEL CIRCOLO ARTISTICO
Un risveglio artistico notevolissimo si determinò nel decennio che va dal 1870 al 1880 e portò una vita insolita nella nostra città. Molti di quei giovani pittori, scultori e architetti, compiuti gli studi a Venezia o a Milano o a Roma, erano ritornati in patria a esercitare la loro professione. Erano questi i pittori Antonio Lonza, Eugenio Scomparini, Alfredo Tominz, Giuseppe Pogna e gli architetti Ruggero Berlam e Giacomo Zammattio.

Si riunivano
la sera in quello storico Caffè Chiozza, oggi scomparso, insieme con i
colleghi più anziani, i pittori Francesco Beda, Giovanni Battista Crevatin, Giuseppe Savorgnani, gli scultori Attilio Depaul, Eduardo
Baldini, Luigi Conti, Francesco Pezzicar, l'ebanista Stella e il
decoratore Abeatici. In unione con Giuseppe Caprin facevano corona a
Giuseppe Lorenzo Gatteri che volentieri s'indugiava a discorrere d'arte
e che tutti ascoltavano riverenti, sopratutto per la sua grande cultura.
A lungo andare, anche per la ragione che alla brigata s'erano aggiunti
molti amici e cultori d'arte, le pareti del Caffè divennero troppo
ristrette ed essi sentirono il bisogno di una casa propria.
Già nel 1873 Antonio Lonza aveva parlato a Giuseppe Garzolini della
necessità, da parte degli artisti, di sottrarsi al monopolio della
Società di Belle Arti, che continuava a organizzare le sue mostre
annuali nel Palazzo Revoltella, e di costituire una società artistica
con locali propri allo scopo di curare i loro interessi senza
intermediari, e di dar vita a una esposizione triestina uscita dal loro
grembo, come aveva veduto fare, con loro immenso vantaggio, gli artisti
di Roma e di altre città.
Ma non tanto questi ultimi erano i motivi che consigliavano una
scissione degli artisti dai fautori di quelle mostre periodiche, quanto
il sapere che coloro i quali le dirigevano erano, nella maggior parte,
d'un colore politico alquanto sospetto.
Giuseppe Garzolini, a istanza del Lonza, dettò allora il seguente
manifesto che fu sottoposto all'approvazione del Gatteri, del Conti,
dello Scomparini, del Pezzicar e di tutti gli altri artisti che
formavano la combriccola del Caffè Chiozza. Il manifesto suonava così:
A Trieste tanto gli artisti quanto i dilettanti di belle arti sono
pochissimi e quasi niente incoraggiati nei loro studi e nei loro lavori.
Le cause principali di questo male sono due: la prima che gli artisti
vivono isolati e poco si curano di far conoscere al pubblico i loro
progressi nelle arti; la seconda è l'egoismo di certuni, ai quali giova
tener occulta l'abilità degli artisti triestini. Per distruggere ambedue
le cause del male nulla sarebbe tanto opportuno quanto il costituire una
Società di artisti e dilettanti triestini o residenti a Trieste, che
dovrebbe avere un'esposizione permanente dei lavori di pittura e di
scultura dei soci stessi.
Ma la cosa rimase a quel punto, senza fare un passo avanti, e il
Garzolini stesso non sa spiegarsene la ragione: forse fu la difficoltà
di raggranellare i quattrini necessari, di trovare le adesioni, i
protettori, i locali adatti; ma più di tutto egli crede di dover
attribuire l'insuccesso al trasferimento del Lonza a Parigi avvenuto
poco dopo, e all'apatia degli altri, che non se ne occuparono né punto
né poco. Fenomeno non insolito fra gli artisti.
Dodici anni dopo questi dovettero sentire però un più forte bisogno. La
Società di Belle Arti aveva chiuso i battenti. Da diversi anni non si
tenevano più esposizioni. L'idea di una società artistica tornò ad
essere discussa. E Riccardo Zampieri, allora reduce da Roma, riuscì a
risolvere il problema. circolo e, rimaneggiatolo adattandolo si dimostrò
scettico intorno alla sua attuazione; ma lo Zampieri, sempre tenace,
anche perché intravvedeva nel futuro circolo un nuovo focolare
d'irredentismo, non si perdette d'animo. Convocò gli artisti nello
studio dello scultore Ivan Rendic, un dalmata dell'isola della Brazza
che da alcuni anni esercitava la sua professione nella nostra città. Non
durò fatica a persuaderli dei benefici che avrebbero ritratto. Tutti ne
furono entusiasti; e iniziarono tosto le riunioni per discutere sulla
futura attività del sodalizio. Quei ritrovi erano improntati al più
schietto buon umore, e ve ne era per tutti i gusti. Non erano
precisamente dei saggi che discutevano, ma dei capi scarichi che
chiassavano. Alle volte parevano riunioni di cospiratori; e, alcuni anni
più tardi, quello studio doveva essere precisamente il teatro di una
cospirazione, quando cioè Leone Veronese mutilò il modello della statua
del monumento della Dedizione di Trieste all'Austria che il
Rendic aveva ultimato. Giuseppe Caprin, che non vi prese mai parte,
persisteva nel suo dubbio: « Ci vogliono quattrini, quattrini » diceva «
e voi non possedete un soldo. »
Ma i nostri artisti non si curavano di simili bazzeccole. Riccardo
Zampieri, che aveva ormai cementato le basi del sodalizio, era intanto
passato da una villeggiatura all'altra: dalle carceri dei Gesuiti a un
soggiorno più alpestre, nel castello di Innsbruck; come redattore
responsabile dell' " Indipendente " scontava il carcere preventivo, in
attesa che gli si facesse il processo.
Giuseppe Lorenzo Gatteri presiedeva le riunioni e gli riusciva difficile
mantenere in equilibrio quei cervelli in ebollizione. Apriva
invariabilmente le sedute con queste parole: Ben, cossa femo? ; e per la
decima volta, prima ancora che la società fosse nata, avvertiva: Guardé,
mi presidente niente! » Poi l'uno o l'altro dava la stura al
discorsetto. Era per lo più lo Stella che si metteva a fare il vocione
da tribuno col risultato di animare l'assemblea.
Il Pezzicar era iroso e scontroso: bastava che uno dicesse di si perché
lui rispondesse di no. Eugenio Scomparini si dimostrava spesso indeciso,
ma se si ficcava in testa un' idea, non c'era che l'autorità di Giuseppe
Caprin che potesse levargliela. Antonio Lonza andava a giornate: mite e
buono, si fidava degli altri, schiacciava il suo sonnellino, ma alle
volte scattava anche lui. Se Giovanni Crevatin arrischiava
un'osservazione, era subito agghiacciato da un'arguzia del Beda. Si
rincantucciava allora vicino al Pogna che, seduto in un angolo, dava
sempre ragione all'ultimo che aveva parlato; con le mani in mano, non
gli mancava che lo scaldino per rassomigliare a un santese. Francesco
Beda faceva dei discorsoni, incominciando le sue filippiche in una
lingua purgata a modo suo per dare un maggior tono di autorità al suo
fare punto dittatorio. Vi innestava qua e là dei triestinismi di sua
fabbricazione che facevano ridere tutti. Se le sballava grosse, rideva
egli stesso, e nel suo strabismo guardava stranamente l'uno a destra e
l'altro a sinistra.
Cosi andarono avanti per qualche mese, finché lo statuto fu pronto e
l'autorità ebbe ad approvarlo, non avendo riscontrato nel sorgere di
questa nuova società, pretesamente apolitica, nessun pericolo per lo
Stato. La riunione generale si tenne nella sala del palazzo Hierschel,
al Corso. Il Consiglio Direttivo riuscì composto di Giuseppe Lorenzo
Gatteri, presidente; di Eugenio Scomparini, primo vicepresidente; di
Giuseppe Savorgnani, secondo vicepresidente; di G. B. Stella, del
negoziante Giorgio Benussi, degli scultori Francesco Pezzicar e Luigi
Conti, del possidente Antonio Caccia, dei pittori Francesco Beda e
Giovanni Crevatin, direttori; dell'architetto Giacomo Zammattio,
segretario.
Quando si trattò di trovare una sede per il sodalizio la cosa si fece
molto seria. Il Gatteri voleva sceglierla personalmente, e ciò non tanto
per ragioni di utilità e di opportunità, quanto per uno scrupolo di alta
moralità. Dapprincipio lo Zammattio, che lo accompagnava, non comprese
subito il motivo per cui, prima di salire le scale di una casa
designata, il Gatteri s'indugiasse in istrada guardando con insistenza
le case dirimpetto e scrutandone le finestre. Quando parve rassicurato,
infilarono le scale. Giunti al primo pianerottolo, il Gatteri apri
un'invetriata che dava nella corte. Nuova scrupolosa osservazione.
Che cosa cerca, signor Gatteri? azzardò lo Zammattio. Lasci fare a
me, rispose, queste cose lei non le capisce ancora. Tutt'a un
tratto apparve rabbuiato e contrariato: voci femminili cinguettavano nel
cortile. Entrambi misero il naso fuori della finestra. Uno sciame di
giovanette, di servotte ciarlavano con altre amiche nel cortile. Il
gioco era abbastanza innocente. Il Gatteri si ritirò risoluto, chiuse
l'invetriata e sentenziò: Non mi piace questa casa: troppe donne! Gli
artisti finirebbero col perdere la testa. E cosi andarono avanti un bel
po', finché, trovata una casa conveniente, il Gatteri poté essere certo
che gli artisti non sarebbero incorsi in pericoli di sorta. Nel gennaio
del 1884 la società s'insediò dapprima in una casa del Corso, con poche
stanze; poi si trasportò in via Genova, nel palazzo Carciotti, dove fu
dato il primo concerto d'apertura, al quale cooperò anche la signora
Salem D'Angeri. I direttori avevano ritenuto opportuno che, prima del
concerto, il presidente tenesse un discorso di apertura. Ma il Gatteri,
uomo di poche parole che non amava chiacchierare in pubblico, rispose: «
Ma che discorsi! Basterà dire che il Circolo si è costituito e
nient'altro!

Un'adunanza del Consiglio direttivo della Società
I colleghi trovarono un po' magro questo antipasto e incaricarono il
segretario architetto Zammattio di tenere il discorso. Questi, infatti,
lo scrisse e lo lesse agli intervenuti che furono oltre duecento.
La cittadinanza vide sorgere con simpatia la nuova società, che aveva
intendimenti e attribuzioni del tutto differenti dalle altre.

Un cartoncino relativo al veglione mascherato promosso dal Circolo Artistico il 25 febbraio 1889.
A questo riguardo
Trieste stava maluccio: la vecchia « Filarmonica » di Francesco Hermet
non era ancora rifiorita; molti triestini, e, bisogna dirlo, anche
politicamente buoni, frequentavano la « Società Schiller ». E' vero che
questa non svolgeva politica militante, ma era pur sempre una società
giallonera. Il primo impiccio politico dei nostri direttori fu provocato
dall'adattamento di una saletta della nuova sede ad Accademia del nudo e
del costume. Per sopperire in parte alle spese necessarie la Direzione
aveva deciso che anche i non soci, signori e signore, avrebbero potuto
approfittarne. La prima ad iscriversi fu la moglie del... direttore di
polizia Pichler; indi una nota baronessa che voleva tirarsi dietro molti
ufficiali dell'esercito. I direttori si guardarono in viso esterrefatti.
Che cosa decidere? In tanto, prima di tutto, niente Pichler, niente
ufficiali e niente baronessa. Ma come cavarsela? Escogitarono una
trovata e le apparenze furono salve: l' invito pubblicato dai giornali
era stato svisato dal proto di stamperia, che arbitrariamente aveva
aggiunto « signore » dove non c'entravano. Cosi gli ufficiali si
trovarono isolati senza la tutela di quelle due signore, e non
comparvero. La società fu salva.
Il Circolo rimase in quella sede per due anni, io non vi posi mai piede,
perché in quel tempo studiavo all'Accademia di Monaco. L'architetto
Giovanni Berlam stava intanto costruendo un edifizio in via Carducci e
preparava un ambiente più ampio per la nostra società, con una sala
abbastanza spaziosa, quella stessa che oggi ospita l'Ateneo Musicale.
Il Gatteri, che io non ho conosciuto, moriva, nel 1884, di marasma
senile a soli cinquantadue anni: egli aveva incominciato a fare il
pittore, si può dire, da bambino, ed era invecchiato presto.
La presidenza fu assunta allora dallo Scomparini. L'architetto Zammattio
aveva lasciato il suo ufficio di segretario essendosi trasferito a
Fiume, dove rimase una ventina d'anni e costruì molti importanti
edifici. Gli succedette Gustavo Hess, professore di disegno e calligrafo
presso le civiche Scuole Tecniche, il quale tenne quell'ufficio per ben
dodici anni.
Fervevano intanto i lavori per la decorazione della sala grande. Il
Circolo era in animazione; tutti gli artisti in gran da fare. Tele di
qua, tele di là, piccole e grandi. In alto, già finiti ornamenti,
puttini e figure. Pareva che ognuno fosse pagato a giornata. Regnava
un'allegria cordiale. Frizzi a getto continuo animavano il lavoro. Fu
allora che comparve l'ultima covata di pittori: intendo parlare di
Isidoro Grünhut, di Umberto Veruda e di me. Eravamo conosciuti soltanto
per qualche saggio d'Accademia. Fummo accolti con grande simpatia e
fraternizzammo ben presto con gli artisti più anziani.
Ma sarà bene, prima di farli entrare in azione, che io faccia conoscere
più da vicino il Grünhut e il Veruda di quel tempo, e specialmente il
primo, cosi poco noto a Trieste sopra tutto perché nel breve corso della
sua vita esplicò la sua attività a Firenze. Qualche piccolo aneddoto
intorno agli ultimi anni dei loro studi varrà meglio a tratteggiare la
loro figura.
Io ero passato dall'Accademia di Vienna a quella di Monaco, dove tutti
allora accorrevano e donde era uscito da poco Ugo Brunetti, un altro
triestino di promettentissimo talento, che si era già fatto conoscere a
Trieste con qualche ritratto di solida fattura, ma che morì purtroppo,
di li a poco, a Costantinopoli. Vi trovai dunque i due sopracitati,
nonché il pittore Eduardo Variano, lo scultore Vittorio Güttner e il
pittore Riccardo Carniel, che poi si trasferì a Parigi, fu combattente a
Domokos, quindi in Francia, durante la grande guerra, dove trovò la
morte nell'Argonne. Tutti triestini e capitanati da quel satanasso che
era Isidoro Grünhut. Egli era piccolo di statura, con un spalla più
bassa dell'altra e la schiena un po' curva e si compiaceva farsi
chiamare il "Gobbo". Era di qualche anno più vecchio di noi e, già
uscito dall'Accademia, teneva studio insieme con Eduardo Variano.
Dipingeva ritratti. Questi ritratti erano a volta a volta della
baronessa X o della sguattera dell'osteria dirimpetto, o d'un ex
ufficiale che l'artista ritraeva a mezza figura in cambio d'un cagnolino
appena nato. Di solito faceva aspettare alle sedute la baronessa o
l'ufficiale; la sguattera lo interessava di più. Il « Gobbo » era un
disegnatore formidabile. I suoi ritratti a matita, che faceva per lo più
al caffè o all'osteria, e che si contavano a centinaia, erano d'una
esecuzione mirabile e d'un disegno cosi serrato e conciso da poter
essere paragonati ai ritratti dell' Holbein; e forse questa castigatezza
della linea e scrupolosità del contorno fecero si che talvolta la sua
pittura se ne risentisse. Isidoro Grünhut era israelita, di padre
tedesco da Ratisbona e di madre anconetana, nacque a Trieste e mosse
prestissimo i suoi primi passi nell'arte. Giovanissimo ancora
incominciò a fare dei ritrattini, e fu proprio nel ritratto che doveva
poi specializzarsi. Non aveva compiuto ancora nessun vero e proprio
studio, quando incontrò a Trieste un certo Benelli, sedicente pittore,
filibustiere di fatto, il quale pensò di sfruttare l'abilità del
giovanetto facendolo vagabondare insieme con lui nelle città del Regno.
Il Grünhut eseguiva dei ritratti e l'altro ci viveva sopra. A Milano si
ammalò e si ridusse quasi in fin di vita. Guarito, ritornò a Trieste, ma
purtroppo col germe del male che doveva condurlo, giovanissimo, alla
tomba. Da Trieste, passò all'Accademia di Venezia, dove rimase un anno;
continuò poi gli studi a Monaco ed ebbe l'appoggio dell'avv. Tonicelli.
A Monaco egli fu virtualmente il nostro maestro. Non aveva mai un soldo
in tasca; era allegro, mangione, mattacchione, un vero gaudente, sopra
tutto però un buon diavolo. Tutti noi, sette o otto, mangiavamo a
credito in una osteria nei pressi dell'Accademia. Alla fine della
settimana il conto non era indifferente. Si pagava come si poteva. Herr
Bühler, l'oste, portava pazienza, perché voleva bene ai giovani artisti,
l'affetto per i quali deve essergli costato, credo, qualche grosso
biglietto di banca. Un bel giorno ci congedò. Il « Gobbo » perorò per
tutti noi. Fu sobrio ma epico: buttarci fuori cosi, su due piedi, senza
neanche un giorno di preavviso, era cosa inumana.
Herr Bühler si commosse: « Ben, vi darò da mangiare anche domani, e poi
basta. » Il « Gobbo » aveva addocchiato una mezza dozzina di pernici che
pendevano da un chiodo nella dispensa e fece tanto, disse tanto, promise
tanto che l'oste acconsenti che le pernici fossero riservate per il
banchetto d'addio dell' indomani. L'oste mangiò con noi, ma poi fu
inesorabile: non volle vederci più.
Umberto Veruda disegnava intanto delle composizioni sensazionali:
Robespierre e Danton erano i suoi ispiratori. Egli e il « Gobbo »
altercavano continuamente, benché fossero amicissimi; e i diverbi
scoppiavano per un nonnulla. Il Veruda era lungo lungo; il « Gobbo » era
piccolo piccolo.
Un giorno, prima del pranzo, cominciano a litigare per la strada. Veruda
dimena tutti i suoi arti, vuole aver ragione e scaglia ingiurie; Grünhut,
al colmo dell'ira, lo lascia per un momento, lo precede a passi
frettolosi, sale sopra un rialzo del terreno e attende. Noi si continua
al passo. Quando Veruda arriva a tiro, Grünhut gli assesta uno
scapaccione con tale violenza da farlo traballare. La scena, svoltasi in
un baleno, fa rider tutti; i due si guardano e si mettono a ridere a
loro volta. Si riconciliarono subito. « È passata » dice Veruda « ma
avresti potuto rovinarmi il talento. » Il problema della vita diventava
sempre più grave. I quattrini, appena arrivati da casa, sparivano per
colmare i buchi fatti il mese avanti. Si desinava spesso maluccio, ma
nessuno si lasciava sopraffare da idee melanconiche.
Intanto s'avvicinava la fine di questo cosiddetto anno di studio. Io ero
venuto a Monaco con l'incarico di eseguire i quattordici quadri della
Via Crucis per la chiesa di S. Maria Maggiore di Trieste. Per Felice
Machlig e l'albanese. Per un principiante come me, era una bella
occasione di farsi onore. Mio padre, che frequentava la bottega di
Felice Machlig, fervente patriota più volte ricordato nei libri del
Caprin e che insieme con Francesco Hermet, Costantino Cumano, Angelo de
Rin e altri fu consigliere nella prima rappresentanza municipale dopo
che fu concesso a Trieste lo statuto civico, s'era spesso incontrato con
don Lino Mistruzzi, cooperatore di quella parrocchia, un prete liberale
ch'era guardato di cattivo occhio dal pretume slavo, il quale formava
allora la curia vescovile, e che, saputomi artista in erba, s'era
arrischiato di darmi quell'incombenza. Ma, a cagione della vitaccia che
si menava a Monaco nel corso dell' intero anno che vi rimasi, non
riuscii
a fare che gli schizzi di due stazioni. Felice Machlig, che ricordo
benissimo, mori quasi novantenne prima del 1900. Era basso di statura e
aveva un nasone ad uncino che pareva facesse da pilota ai suoi occhi
estremamente miopi e che continuamente scrutavano le immediate
vicinanze, ma che più d'una volta l'avevano tradito. Si raccontava che -
sensibile com'era sempre alle apparizioni femminili - gli fosse capitato
una volta di inseguire due polpacci calzati di bianco e che, dal volume,
potevano appartenere ad un pezzo da cento. Uscivano da una gonnella
corta tutta a pieghe e sollevata forse perché pioveva a dirotto. Un
grande ombrello gocciolante nascondeva il resto. Dopo aver pedinato a
lungo quelle due estremità, si fece intraprendente; ma fu servito male.
Quel donnone gli fece vedere il viso fornito di due irti mustacchi e gli
occhi inferociti che lo minacciavano: era un albanese vestito nel suo
costume nazionale.
Una mattina, recatomi nello studio del « Gobbo, dove lavoravamo in nove
o dieci accavallati uno sull'altro senza perciò aumentare di molto la
nostra produzione, scorsi dinanzi alla porta un prete in attesa. Nel
vedermi, mi scruta, mi esamina e infine mi dice in italiano: « Lei è
Wostry, è vero? Rimango sorpreso. Si presenta: don Pietro Tomasin di
Trieste, inviato da don Lino Mistruzzi per vedere i progressi che
facevano i quadri della Via Crucis. Allibisco; lo faccio entrare;
borbotto: «Mi dia il cappello... si copra... Ecco...no, veda... sieda...
Quei quadri, quasi finiti, si trovano... sieda, prego... nello studio di
un mio amico, molto distante dalla città, perché, vede, reverendo, là
fuori si lavora meglio: qui siamo in troppi .. Permetta intanto che le
presenti... Grünhut, Variano, Veruda, Güttner... » « Già, » confermano
tutti in coro « i quadri sono quasi finiti! » Mi sentivo agghiacciare
dal sudore freddo; ma don Tomasin se ne rallegrò, lieto di portare una
buona notizia a don Lino. Per fortuna non mi chiese di vedere i quadri:
egli doveva sbrigare molte altre faccende a Monaco e vi s'intratteneva
soltanto brevissimo tempo. Intanto da casa mia avevo ricevuto una
paternale coi fiocchi che mi aveva fatto molta impressione: m'era stato
ingiunto di far subito ritorno a Trieste. Mie sorelle mi mandarono
nascostamente i loro piccoli risparmi per le spese di viaggio. Avrei
dovuto partire entro pochi giorni; e anche Grünhut e Veruda mi avrebbero
seguito a breve intervallo. Il « Gobbo », qualche tempo prima, aveva
preso una stampa, l'aveva ricopiata sulla tela e poi colorita. La firmò
cosi: Roba de Capoto. Ora il quadro stava asciugando.
Glielo aveva comperato un negoziante di formaggi per duecento marchi; il
denaro doveva servire per il viaggio di tutti e due.
Le mie robe si trovavano in una stazione poco discosta da Monaco, dove
con l'aiuto degli amici le avevo portate di notte, per la semplice
ragione che qualche creditore, non so se oste, sarto o calzolaio, aveva
subodorato la mia, anzi la nostra partenza. Ognuno di noi aveva partite
aperte con questi messeri, ed eravamo posti, per così dire, in istato
d'assedio. I miei debiti si aggiravano intorno ai duecento marchi, ma
devo dire, ad onore del vero, che pagai i miei creditori con i primi
soldi che guadagnai. Tutti gli amici presenziarono alla mia partenza.
Saluti, strette di mano e... via! Avevo acquistato un biglietto diretto
fino a Trieste e qualche piccola provvista per il viaggio; mi restavano
ancora in tasca venticinque soldi, tanto da potermi prendere il lusso di
un caffè in qualche stazione. Arrivai alle cinque del mattino a Lubiana.
Tutti i viaggiatori dovettero scendere. « Come! Non prosegue per Trieste
questo treno? »« Bisogna che lei aspetti qui quello che arriva questa
sera alle sei. » Impallidii. Che fare ?.. Ruminai a lungo, ma non avevo
altro partito da scegliere. Quando fu giorno, mi recai al telegrafo:
volevo pregare la mia famiglia di mandarmi telegraficamente cinque
fiorini per poter campare quella giornata. Stilizzai in questo senso il
telegramma. L'impiegato, che comprendeva l'italiano, legge, annota. «
Quaranta soldi, » mi dice. « Ma scusi, » rispondo, « non dico nel
telegramma che sono senza un soldo e che attendo qui questo assegno?
Pagherò quando giungerà la risposta. » « Ma lei è matto, » mi risponde,
vada per i fatti suoi. » Girai così tutta la giornata la città, che mi
parve assai antipatica; ma forse la vedevo tale a cagione del mio
stomaco vuoto! Quando Dio volle, passò il treno, e, alla sera, nuovo
figliuol prodigo, mi trovai a casa. Nel vedermi, tutti presero paura.
Avevo un cappellaccio da brigante, lunghi capelli incolti e una
barbaccia che incominciava a spuntare mandando fuori qua e là dei
ciuffetti di pelo senza continuità e senza disciplina. Fame, poi, ne
avevo in abbondanza! Pare che quella sera divorassi tutto ciò che di
commestibile si trovava in casa. Avevo vent'anni !
* * *
Quando Umberto Veruda giunse a Trieste, trovò ch'era necessario dare
qualche ritoccatina al suo esteriore prima di presentarsi ai colleghi
per guadagnarsi immediatamente la loro considerazione. Era alto come una
pertica e magro magro. Aveva la faccia simile a quella di un puttino
che, modellata in argilla, si fosse deformata nel cadere dal bilico.
Aveva la fronte alta e prominente; il nasino rientrato lasciava visibile
soltanto una pallottolina piantata all'insù: pareva che un Torrigiani
avesse fatto anche a lui quel tale servizio del quale era stato
gratificato Michelangelo. Qua e là spuntavano dei peli interrotti da
piccoli vulcani in eruzione, e mi diceva talvolta d'aver timore che il
talento gli scappasse da quei foruncoli.
Appena giunto, m'invitò di andare con lui dal sarto. Voleva farsi fare
un vestito ultra
verudiano. Fra molte stoffe ne scelse una molto appariscente e di suo
gusto: a grandi
quadri neri su fondo color caffè : una scacchiera. E tanto fece, che
ordinai un vestito
simile per me. Fin qui nulla di male; ma per lui non bastava ancora.
Trovava che l'intonazione
generale non aveva peranco la linea desiderata; ordinò perciò al
calzolaio un paio
di scarpe di forma tutta sua. Erano allora di moda con la punta stretta: lui le volle con
la punta tagliata ad angolo retto. Il calzolaio lo accontentò per filo e
per segno. Egli ne
fu soddisfatto, e lo consigliò di scrivere sulla sua insegna: a
Fornitore brevettato del pittore
Veruda.
Il primo giorno che fece la comparsa col vestito nuovo e con le scarpe
come sopra,
si recò dal barbiere e si fece radere completamente la testa e i pochi
peli del viso. Divenne
delizioso! Il giorno seguente passeggiò ininterrottamente su e giú per
il Corso. I frequentatori
del liston erano, come sono, persone civili; e, salvo qualche commento
più o meno
salace per quella apparizione inattesa, egli poté dire di aver raggiunto
lo scopo. Osservò
soltanto che per ottenere un successo completo gli era mancato il cane
senza coda del
defunto Alcibiade! Il grave fu quando dovette far ritorno a casa e
passare per la via
Barriera vecchia (oggi Corso Garibaldi), e, peggio ancora, imboccare la
strada che si
chiama del Molino a vento, dove dimorava. Da Piazza Grande, a fare un
salto lassù
voleva dire fare un salto nell'Uganda. Lo Zangrando lo aveva
accompagnato per un tratto
di strada e quando giunsero in quei paraggi, vide un beccaio che intento
com'era ad
appendere un ossobuco in mostra, all'apparizione del Veruda se ne
ristette e sgranò tanto
d'occhi, e come ebbe timore che colui dimostrasse la sua sorpresa in
maniera troppo persuasiva,
disse in fretta addio addio al Veruda e lo lasciò solo. Ma questi
prosegui come
se il fatto non lo riguardasse, e poi giornalmente imperturbabilmente
passava per quella
regione con la massima disinvoltura. Dipoi
anche i selvaggi » finirono con l'abituarsi
alla sua apparizione e, salvo qualche parolina
all'acido solforico del loro vocabolario,
lo lasciarono in pace.
Al Circolo ebbe un successo immediato.
Isidoro Grünhut impiegò più
tempo a guadagnarselo, ma quando l'ebbe
poi raggiunto, i colleghi si ricordarono di
lui per tutta la vita.
Quanto a me, si trattava ora di
mettersi a lavorare seriamente. Quel tuffo
nella bohème mi aveva fatto bene. Già
all'inizio avevo preso la vita troppo sul
serio; quell'anno di spensieratezza m'aveva
alleggerito lo spirito. Alla fine però
m'ero stancato e n'ero uscito contento.
Feci visita a quel buon don Lino e gli
raccontai che una parte dei quadri finiti
si trovava già in viaggio per Trieste, ma
che li avevo spediti a molto piccola velocità
per risparmiare nel trasporto. Mi
credette e attese. Avevo promesso una
cosa che non sapevo io stesso se avrei
potuto mantenere. Fino allora non avevo
fatto che studi e qualche ritratto non tanto
disprezzabile; ma non avevo mai eseguito
ancora un quadro di composizione,
e il mio compito non era facile. Dovevo
far muovere in un budello di tela, largo
novanta centimetri e alto due metri, delle
figure grandi al naturale e in quattordici
scene differenti. Le tele dovevano coprire
delle nicchie, nelle quali, in origine, avrebbero
dovuto trovar posto delle statue.
Presi in affitto uno stanzone. Pochi i mobili: qualche seggiola, un
tavolo e un cavalletto.
Tutto il resto doveva balzare dalla mia
testa. A dire il vero, quando mi trovai faccia a faccia con le mie quattordici tele tutte
bianche, rimasi un po' scombussolato.
A cagione delle mie bugie, don
Lino, sicuro del
fatto suo, aveva stabilito che la consacrazione dei quadri avrebbe
dovuto aver luogo nei
primi giorni del marzo 1887, ed eravamo nel novembre 1886. Avevo dovuto
accettare tali condizioni senza obbiettare. Mi misi subito all'opera e mi
giovai dei primi due abbozzi
eseguiti a Monaco. Avevo trovato un modello che divenne una specie di
bonne à
tout faire dello studio: accendeva la stufa, faceva la pulizia, lavava i
pennelli, posava da
Cristo, da Cireneo e qualche volta da Maddalena per i panneggiamenti.
Era friulano: un
pezzo d'uomo due volte me. Abbandonata poi l'arte, quand'ebbi finita la
Via Crucis, tornò
al suo mestiere di fattorino e, nelle sere di spettacolo, da
guardaportone del Teatro Comunale.
Alla fine del febbraio successivo terminai i quattordici quadri, con i
quali allestii
un'esposizione nella sala terrena della Borsa. Don Lino era gongolante,
benché io, nella
fretta dell'esecuzione, avessi in qualche quadro un po' maltrattato il
Salvatore più di quanto
avevano fatto gli Scribi e i Farisei.
***
Questi erano i tre pittori dell'ultima nidiata di quel tempo, che si
offrirono di dare
una mano ai colleghi
più anziani nell'allestire la nuova sala del Circolo.
Finalmente compiuta la sera del febbraio 1887 ebbe luogo l'inaugurazione con un bellissimo concerto
organizzato dai maestri
Sinico e Zampieri. Fu eseguito, fra altra musica, lo Stabat Mater
del Pergolesi, e
cantò Italia
Vasquez-Uccelli, triestina,
che fu
poi per molti
anni prima
donna all'Opera
di Buda-Pest, e un
coro di signore
istruite
dal maestro
Zesevich.
Quale
introduzione
Piero Vendrame
disse,
come sapeva
dire lui, il Carme all'Arte scritto
da Riccardo
Pitteri.
L'attività del Circolo si
esplicò quindi nella maniera
più promettente. Ai concerti
e ai ritrovi si succedevano le
conferenze di argomento artistico
e letterario, e durante il
carnevale le feste e i balli in
costume fecero chiasso. I soci
aumentavano; ogni sera funzionava
l'Accademia del nudo
e del costume, frequentatissima.
La biblioteca sociale si
arricchiva continuamente di
pubblicazioni artistiche e di
preziose opere che già formavano
una raccolta utilissima
agli artisti. Subito dopo
fu tenuta al Museo Revoltella
la prima esposizione di Belle
Arti, organizzata con premi. I 51
biglietti-azioni costavano cinque
fiorini ciascuno. Tutti gli
artisti regalarono delle opere
(Cesare Dell'Acqua mandò da
Bruxelles un suo pregevole
acquarello), che furono sorteggiato
fra gli azionisti.
In quel tempo fu tenuta la prima "sabatina", promossa da Giuseppe Caprin, il
quale era divenuto il padre putativo di tutti, giovani e vecchi, e
finché visse non tralasciò
una sola sera di frequentare il Circolo. Il tresette lo aspettava. Era
bonario con tutti, ma
aveva le sue antipatie che non sapeva nascondere. Qualcuno gli si teneva
a distanza,
perché il suo fare autoritario metteva talvolta soggezione. Coi giovani
era indulgente. Per
festeggiare la nomina dello Scomparini a professore della Scuola
Industriale allora istituita,
il Caprin organizzò una festa in suo onore incaricando il Veruda e me di
eseguire le
caricature degli artisti per presentarle in quell'occasione. I quadri
erano grandi due metri
ciascuno, e alcuni frammenti si conservano ancora al Circolo. Fu
allestito un vero banchetto: lo Scomparini, festeggiatissimo, ne rimase sorpreso e commosso. Il
Caprin gli rivolse
un discorsone fra il serio e il faceto, che volle firmato dagli artisti
caricaturati, di ciascuno
dei quali, come passavano dinanzi al festeggiato, fece la presentazione.
Ebbe delle trovate
felici, piene di spirito. La serata fu brillantissima.
Poco tempo dopo lo Scomparini volle la rivincita nel suo studio, dove ci
invitò
tutti. Questa volta il programma fu
diverso: gli artisti dovevano presentarsi
come poeti e scrittori; questi,
viceversa, come pittori e scultori.
I capolavori presentati dal
Pitteri, da Giacomo Rota, Felice
Venezian, Alberto Boccardi, Giuseppe
Caprin, Attilio Hortis, Cesare
Rossi, Giglio Padovan, Giuseppe
Garzolini rimasero molto
tempo nel suo studio come ricordo.
Erano della più grande
comicità. I più degli scrittori s'erano
rivelati paesisti. È evidente
che quella volta furono giudicati
con preconcetto; oggi sarebbero
guardati diversamente. Ma i tempi
non erano ancor maturi, perché
simili manifestazioni precorritrici
dell'arte nuova fossero comprese.
Qualcuno riportò l'impressione che
il terremoto avesse messo fuori di
piombo i caseggiati nel dipinto di
Giuseppe Caprin, e non era che
mal compresa genialità; qualche
altro trovò che Felice Venezian non
dimostrava affatto talento; il Rota,
il Pitteri e il Boccardi furono accolti
poco seriamente, ma tutti furono
inesorabili col ritratto dipinto
da Attilio Hortis che dicevano avesse avuto per modello una zucca.
Piero Sticotti deI nostro Museo di Storia ed Arte è riuscito ad avere
quattro di questi esemplari per conservarli
a ricordo di questa famosa festa d'arte. Ma credo che egli, previdente
com'è, sia stato animato anche da un'altra
intenzione, e lodevolissima: di conservare cioè questi prodotti,
pensando che forse un giorno verrà ad essi assegnato
il posto che loro spetta, salendo al rango di precursori dell'arte
novecentista. Sgraziatamente gli altri sono andati perduti.
Tuttavia devo dirlo: Braque, Van Dongen, Dufy, Billette, Caillard, mi
dispiace per voi ma la Francia non ha il primato
nel nuovo movimento artistico. Siete stati anticipati da questi miei
amici di almeno dieci anni.
Di sculture ve n'era una sola, ma buona. Un gruppo di piccole
proporzioni, notevole
per il disparato materiale che l'artista aveva impiegato per
confezionarlo: maccheroni
e roba del genere. Era intitolato Paolo e Francesca, Paolo portava per
cappello un
guscio d'uovo, arricchito di una piumetta rossa tolta da uno
spolveratore, che gli andava
a meraviglia. Il Garzolini, che n'era l'autore, aveva anche lui
precorso di molti anni quel
bricconcello di scultore russo Archipenko, che aveva composto una statua
di donna con
tubi da stufa e simili, e i cui seni erano costituiti da due imbuti,
opera che figurò prima
al Salon di Parigi e poi anche a una Biennale Veneziana. E per quali vie
il nostro artista
venisse ispirato, lo spiegava egli stesso cosi : A quei tempi, di
carnevale, ogni osteria, o
« locanda che fosse, apprestava a mezzanotte il risotto per i
frequentatori dei veglioni del
«Teatro Armonia, del Politeama Rossetti o del Comunale, come si chiamava
l'attuale Verdi,
«nonché per coloro che ballavano in sale private. Era il piatto
tradizionale di quelle nottate,
« annunziato con l'invariabile avviso: « A mezzanotte in punto,
risotto ». Commosso ai casi della bella figlia di Guido da Polenta e di Paolo, volli tradurre in
plastica la mia commozione e offrirla al festeggiato. "Ardito quanto contradditorio
concetto, poiché quei duo che insieme vanno, anziché al vento esser leggeri, erano prosaicamente
materializzati. Stretti l'uno all'altro, forse più del conveniente bisogno, come
colombe dal desio portate, s'attardano stupiti davanti alla porta di un'osteria, dove leggono
l'immancabile scritta che
«ricordava loro il desiato riso ! »".
Anche noi giovani c'ingegnammo. Non si rimase al di sotto dei primi.
Furono bestialità
monumentali. Il « Gobbo » lesse una poesia irriproducibile; il Veruda si
presentò
con un poema a metraggio tanto lungo, che a un dato momento fu
investito da tutti in
maniera poco lusinghiera. Non la finiva più! Erano vocaboli
altisonanti, messi insieme a caso
senza significato. Qualcuno lo afferrò per gli stinchi; voleva fargli
abbandonare la tribuna.
Intervenne Hortis: « Gli avete dato il purgante, lasciate che si liberi.
» Finì col liberarsi
anche lui. La festa ebbe esito lietissimo.
Poco tempo dopo Giuseppe Caprin ci volle tutti a casa sua. Nel grande
salone era
stata imbandita una bella mensa; la sua cucina non smenti la fama che
godeva. Ogni
commensale aveva la sua boccaletta dipinta e con il proprio nome.
L'attività del Circolo si sviluppava sempre con maggior successo, dato
il numero
rilevante dei soci, saliti a seicento.
Lo Scomparini era un brillantissimo presidente, che faceva gli onori di
casa con
garbo e che si sdoppiava per accontentare tutti. Gli altri direttori lo
assecondavano. Facevano
allora parte del Consiglio Direttivo il Pitteri, il de Preschern, suo
cugino, il
Lonza e Giacomo Rota, il baritono che aveva avuto grandi successi e
relativi quattrini
in Russia e in America ed era amicissimo di Giuseppe Verdi. A Trieste
non aveva mai voluto
cantare. Portava anche lui la sua nota di distinzione.
Il nostro piccolo mondo artistico si era accresciuto di un altro membro,
dell'architetto
Enrico Nordio che, lasciata la direzione della Scuola Industriale di
Trento, era ritornato
nella sua città natale per insegnare nel nostro Istituto Industriale.
Era poco più
che trentenne. Dopo gli studi al Politecnico di Vienna ebbe un maestro
pratico nell'architetto
Schmidt, del quale divenne collaboratore nei restauri del duomo di Santo
Stefano
di Vienna come pure nella costruzione di quel palazzo di città. Poco
dopo ebbe campo
di rendere manifesta la sua capacità artistica vincendo, a parità di
merito col Beltrami e
con un architetto francese, il concorso per la ricostruzione della
facciata del duomo di
Milano indetto da quel comune. La notevole distinzione rallegrò i
colleghi del Circolo che
gliene diedero una dimostrazione sincera organizzando una serata in suo
onore. Luigi
Conti modellò un cavallo di gesso che fu collocato sopra un basamento.
Sul cavallo fu
posto un manichino drappeggiato. Enrico Levi modellò il ritratto del
Nordio. Le minute del
pranzo portavano riprodotto in testa il suo progetto milanese, ch'era
via via ripetuto in
ogni oggetto e in ogni canto.
Si pensò quindi a una grande festa in costume, con relativa
trasformazione della
sala. L'accordo fu presto raggiunto: l'Egitto doveva farne le spese.
Sala, antisala, gli
altri locali, tutto divenne egiziano. Chi non sapeva lavorare, faceva da
garzone. Anche
Pitteri e Rota portavano pignatte di colori, reggevano le scale, stavano
insomma al nostro
servizio. Ogni angolo fu trasformato. Iside, Osiride, Oro in tutte le
salse; Faraoni a manciate,
sugli stipiti delle porte, sulle colonne, da per tutto. I partecipanti
sfoggiarono bellissimi
costumi. Nei giorni seguenti le sale rimasero aperte al pubblico che vi
ammirò la
completa e riuscita trasformazione.
Nell'anno 1887 si tenne per la prima volta il concorso al premio di Roma
per pittori
e scultori, fondato dalla baronessa Cecilia de Rittmeyer in memoria del
marito Carlo
barone de Rittmeyer, benemerito negoziante triestino di origine
svizzera, che per molti
anni fu presidente del Curatorio del Civico Museo Revoltella. I
concorrenti furono cinque:
tre pittori e due scultori. I primi erano Isidoro Grünhut, Umberto
Veruda e io. La giuria
decretò il premio a me, ma nel medesimo tempo il barone Giuseppe de
Morpurgo, allora
presidente del Curatorio del Museo, dopo il responso della giuria,
recatosi al Tergesteo,
raccolse li per li una somma eguale a due altre borse di studio che
furono conferite al
Grünhut e al Veruda. Ma di questo studio di Roma non potei fruire che
pochi mesi, perché
mi colse un'infermità agli occhi, che mi durò oltre due anni rendendomi
per sempre inservibile
l'occhio sinistro. Da principio mi risentii di questa limitazione; poi
mi rimisi a lavorare.
L' impressionismo aveva finito per fugare gli artisti dagli studi. Tutti
lavoravano all'aperto. Anche noi addocchiammo una campagna al Boschetto e vi fondammo
la nostra
piccola colonia. Tutti i giovani vi convenivano, e spesso anche gli
anziani. lo piantai un
quadrone di quattro metri. Soggetto classico: Dafni e Cloe. Poi,
insieme con altri,
feci una esposizione nella sala terrena della Borsa. In quell'occasione
Riccardo Pitteri pubblicò
nel « Piccolo » la poesia:
Dafni e Cloe (a Carlo Wostri).

Nel 1911 il Circolo Artistico ordina, per la seconda quindicina di gennaio, una Mostra e Concorso di ventagli artistici antichi e moderni.

La prima esposizione biannuale del Circolo Artistico si svolse tra il 14 settembre e il 26 ottobre 1924.
Grande successo ebbe l'anno successivo una festa medievale progettata dall'architetto Nordio, il quale trasforma i locali del Circolo nell'interno di un maniero. Il sussidio dei pittori gli fu efficacissimo. Diverse trovate geniali completarono l'opera. Molti i costumi e originalissimi; indossati da chi sapeva portarli. « II Nordio stesso - racconta Giuseppe Garzolini - vestiva la ferrea « armatura di un cavaliere del XII secolo, armatura autentica avuta a prestito non so più da chi, e che lo doveva rendere il pernio della festa in fatto di vomeni d'arme.
Questi successi del
Circolo attirarono molti nuovi soci: ciò che impensierì la Società
Filarmonica, la quale, da poco rinata a nuova vita, aveva le sue sale
poco frequentate. Si sapeva che al successivo congresso la Direzione
avrebbe trovato degli oratori di opposizione, e cosí fu. Felice Venezian
parlò nel senso su esposto e il Caprin gli tenne bordone. Generalmente
si davano molte colpe alla nostra Direzione, non ultima quella di aver
fatto del Circolo una palestra di balli e di divertimenti. Per i nostri
soci rispose Oscar Menzel. La discussione fu lunga e animata, ma a
qualche cosa servì.
Per dimenticare queste malinconie, un sabato rappresentammo « Il
Trovatore » in edizione ridotta. Fu una « Sabatinona » coi fiocchi. Fu
costruito un teatro, furono dipinti i scenari, disposta l'attrezzatura
in modo che non vi mancava nulla. Eleonora era quel colosso di De Amicis;
Manrico, Pepi Marass; il conte di Luna, lo Zangrando, per il quale
l'impresa spese di bei quattrini nel fargli apprendere la parte.
Qualcuno s'era imbattuto in un maestro di musica tedesco che
pazientemente lo tirò su can...tante! I vecchi artisti contribuirono
all'esito della festa con trovate di spirito nuove di zecca, ma le più
non sono narrabili. Molti i regali, le poesie, le dediche agli artisti.
Lo Scomparini, con pensiero zoofilo, non aveva omesso di collocare al
proscenio una di quelle mastellotte ripiene di acqua e zolfo, legate a
una catenella, che in passato si mettevano durante l'estate nelle
strade, a intervalli, per uso dei cani. Prima della rappresentazione,
Oscar Menzel disse un prologo scritto in versi martelliani dallo Zemba.
L'anno seguente il Circolo organizzò una seconda esposizione di opere al
Museo Revoltella. Vi parteciparono molti bei nomi di artisti d'oltre
confine, ma due quadri, due vere gemme, vi destarono il maggiore
interesse, anche se tutti non ne compresero la tecnica, che in Francia
aveva già guadagnato buon numero di proseliti: il divisionismo. I due
quadri erano del Segantini: « L'aratura » e « In campagna ». Ad onore
della verità è doveroso dire che Giuseppe Caprin fu in quella volta fra
i pochi a comprendere la grande arte di questo maestro la profonda
poesia dei quadri. I più giudicavano l'opera d'arte attraverso la
tecnica. Invano egli perorò in seno al Curatorio del Museo Revoltella
perché la tela « L'aratura », che costava tremila fiorini, fosse accolta
nella nostra collezione. Oggi il quadro è conservato come un gioiello
nella Pinacoteca di Monaco di Baviera.
Dopo il periodo neoclassico, che per Trieste segnò qualche splendore edilizio per merito di quegli architetti di cui s'è parlato da principio, il quadro dell'architettura cittadina si mostrò piuttosto squallido e disadorno. Predominavano le case prive di ogni sorriso d'arte e qua e là si verificavano dei tentativi di stili medievali mal compresi, o di quel gotico Luigi Filippo, che fu brutto nel suo paese e ancor più dove veniva importato. Fu merito precipuo dell'architetto Giovanni Berlam di avere portata una ventata d'arte in tanto squallore; parecchie sue costruzioni fanno ancora oggi onore al suo nome. Nel 1878 egli ebbe il validissimo aiuto di suo figlio Ruggero, che fu l'architetto pittore per eccellenza. In città si contano una cinquantina di edifici costruiti da lui, tra palazzi, case e ville. È disegnata da lui la bella scalinata all'imbocco della galleria di Montuzza, la Scala dei Giganti, e sono opere sue il palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà e la bellissima Sinagoga. A sua volta, questi ebbe la collaborazione di suo figlio Arduino.

Concorso per il Monumento al Re Galantuomo in Roma (Progetto di Ruggero Berlam)
Piero Sticotti, nel discorso commemorativo tenuto al Circolo Artistico
la sera del 2 dicembre 1920, e pubblicato nell'Archeografo Triestino del
1921, in omaggio a questo artista morto pochi mesi prima, nel metterne
in rilievo le eminenti qualità, narrò la sorte toccata al suo progetto
per il monumento al Re Galantuomo a Roma. La storia del monumento a
"Vittorio Emanuele" - dice lo Sticotti - me la raccontò Attilio Hortis
alcuni giorni fa ed io ve la ripeto. Ruggero Berlam, consultandosi con
lui riguardo al concetto storico dell'opera, aveva preparato un
magnifico progetto per il monumento. Avvenne poi che l'artista,
sospettando di trovar chiuse le barriere, ricorse al contrabbando. Da
Trieste mandò il progetto a Milano e di là lo fece partire per Roma. Il
progetto arrivò in questa città verso la fine del 1883, fu esposto e fu
lodato.
Quando, non si sa come, il governo di Depretis subodorò la frode, ed
assunte informazioni fu assodato che la merce era venuta d'oltre Iudrio,
il progetto fu fatto sparire. Un giornale d'arte che usciva allora a
Roma sovvenzionato da un principe Odescalchi scrisse in proposito: « Il
primo concorso è stato vinto da un francese e questo sarà vinto da un
austriaco, né più né meno.
Intorno a questo tempo s'era stabilito a Trieste Luigi Zabeo, veneziano.
Fu generalmente poco conosciuto, giacché lavorava per conto di ingegneri
e di costruttori triestini. Disegnò la bella facciata del palazzo
Economo in Piazza della Libertà e quello delle Assicurazioni Generali di
cui progettò anche il sontuoso scalone. Il governo e le società
semigovernative, neanche a dirlo, ricorrevano all'opera di artisti
tedeschi per le loro costruzioni. Sorsero cosi il palazzo del Lloyd del
Ferstel, la stazione della Meridionale del Hansen e il palazzo della
Prefettura dell' Hauptmann.
Fu pure in quel tempo che il nostro Municipio affidò il difficile
compito di adattare i tre edifici esistenti a Palazzo Municipale con
facciata unitaria, all'architetto triestino Giuseppe Bruni ed accolse
nel proprio ufficio tecnico l'ingegnere triestino Giorgio Polli e il
fiorentino Icilio Turri, che conferirono garbo artistico a tutte le
costruzioni municipali che vennero loro affidate. Sono opere encomiabili
del primo la Sede del Monte di Pietà e la Pescheria. Il secondo portò un
novello contributo alle costruzioni di stile fiorentino. Intanto
l'architetto Giacomo Zammattio svolgeva la sua brillante attività nella
vicina Fiume. Ritornato poi a Trieste, operò qui e fra i molti suoi
edifici notabili va menzionato per primo il sontuoso palazzo dell'ex
Società Greinitz in Corso Vittorio Emanuele III. Un grande contributo
all'edilizia triestina portò l'architetto Enrico Nordio. Studiò
nell'Accademia di Belle Arti di Vienna sotto la guida di Federico
Schmidt, appassionato cultore di stili medievali. Ma la sua scuola
pratica la ebbe durante i suoi viaggi di studio in Toscana, nell'
Umbria, nel Lazio, a Roma. È superiore al credibile quanto egli abbia
disegnato, rilevato, misurato. E da questo esercizio derivò quella
perizia del disegno e quell'eleganza di tratto che rimasero sempre la
sua caratteristica. Dopo aver dedicato le sue cure ai restauri del duomo
di Trento e della chiesa di S. Maria Maggiore della stessa città,
partecipò al concorso per la facciata del duomo di Milano. Duolmi di non
avere un disegno da riprodurre di questo suo progetto. Poi esegui mano a
mano i progetti della Cassa di Risparmio Triestina, della casa Mordo in
via Roma, in istile gotico veneziano, e di altre. La sua opera
principale è il palazzo della Banca Commerciale Italiana,
originariamente costruito per la Banca di Credito Fondiario. Unitamente
a Ruggero Berlam, affrontò il problema dei restauri di S. Giusto. Per
ultimo vinse col suo progetto il concorso per l'ultimazione del palazzo
di Giustizia.
Degli architetti più giovani parlerà qualcun altro dopo di me.
***

IL CAFFÈ CHIOZZA
L'adunata degli artisti al completo era rimasta sempre al Caffé Chiozza. Vi convenivano Pezzicar, Baldini, Conti, Rendic, Lonza,
Crevatin, Beda, Pogna, Baikoff (un paesista russo), Savorgnani padre e
figlio, Scomparini, Garzolini, lo scultore Levi, Turri, Moro, Marass,
Hess, Ballarini, Caratti, Novelli e altri. Di quella vecchia guardia non
restano che pochissimi.

Antonio Lonza era da poco ritornato da Parigi, dove aveva avuto buoni successi con i suoi quadri fatti alla maniera del Fortuny, tanto in voga a quel tempo. Molti furono ammiratissimi, specialmente quello intitolato «Duro pane ». Notevolissimo fu poi il suo quadro le « Fioraie » eseguito qui e che si staccava da quella maniera: ebbe molte riproduzioni in periodici d'arte. Fra i primi suoi quadri noto il « Gerolamo Savonarola » del nostro Museo Revoltella. Il Lonza fu un ottimo cuore, ma punto tormentato da grandi aspirazioni. I suoi buoni occhi azzurri, calmi e sereni erano spesso fissi alle nuvole. Esigenze non ne aveva. Alla sera la partita a tresette col Pitteri, lo Scomparini, il Caprin e il Conti; il sigaro « Virginia » costantemente fra le labbra.

Lo Scomparini era un bell'uomo, alto, forte e slanciato. Si compiaceva di essere il beniamino viziato da tutti. Fino alla costituzione del Circolo aveva menato la gran vita con gli eleganti della città. Era di buonissimo carattere e genialissimo. Aveva avuto ottima scuola e disegnava bene. Dal suo temperamento artistico si sentiva portato alla grande decorazione di tipo tiepolesco e ne fece di bellissime. Sentiva una forma d'arte dalla quale non si staccò fin che visse, rimanendo fedele alle sue convinzioni artistiche. Sono di questo periodo, oltre all' « Amleto » già accennato, un' « Ofelia », un « Otello » e il sipario del Politeama Rossetti.

Francesco Beda, eternamente di buon umore, trattava gli stessi soggetti del Lonza, ma più leziosamente. Prendeva gusto a dare istruzione ai giovani sulla maniera di fabbricare un quadro. L'esecuzione dipendeva dal prezzo di vendita. I tedeschi pagavano di più, e allora l'aggiunta di quattro pennellate faceva guadagnare un nuovo cliente. Egli fu uno dei tipi più esilaranti del Circolo. Toccava la cinquantina. Aveva una figura alquanto scombussolata nelle linee: il naso rispettabile voltato un po' a sinistra, e dalla stessa parte, per strabismo, tendeva anche uno dei suoi occhi. Giocatore di bigliardo impenitente, faceva ogni sera la partita col Crevatin, e l'assistervi era una commedia. Tutti e due erano bravi giocatori.

Il Crevatin prendeva la cosa più sul serio, e ciò gli attirava i motteggi del Beda che li accompagnava con uno scoppiettio di frizzi di caustica bonarietà. Era uno spasso per tutti. Se il Crevatin perdeva, non voleva ammettere la sua casuale inferiorità. Ne dava la colpa alla moglie, che alla mattina gli aveva fatto infilare delle calze troppo grosse o dei polsini che gli solleticavano la pelle. Il figlio del Beda, Augusto, pittore paesista, si stabili a Monaco dove si fece un bel nome.

Giovanni Battista
Crevatin in arte era l'uomo dei dubbi, delle titubanze, delle
pedanterie.
Per il suo grande quadro « Diana cacciatrice », intorno al quale lavorò
dieci anni, s'era fatto costruire nel suo studio tutto un macchinario:
manichini vestiti, piante artificiali, un cigno impagliato, il tutto
illuminato dalla luce del finestrone dello studio. Poi copiava
meticolosamente ogni particolare, con tanta lealtà da far rabbrividire!
Ognuno che lo visitava nello studio gli diceva
la sua : « Mi pare questo, mi pare quest'altro »; ed egli mutava,
mutava, mutava...
Ivan Rendic, allievo
del Dupré, era un facile modellatore. I suoi monumenti si succedevano ai
busti e alle statue con una speditezza incredibile. Da un comitato
cosidetto « patriottico », composto della schiuma giallo-nera triestina,
venne dato a lui l'incarico di eseguire quel monumento che doveva
ricordare il 500° anniversario della dedizione di Trieste all'...Austria
e che sorse poi in Piazza della Stazione centrale e fu demolito dopo la
redenzione.
Il Rendic aveva accettato quell'incombenza senza andar troppo a
sottilizzare. Da quel burlone che era, voleva fare anche di questo
monumento una specie di equivoco. « Un giorno » diceva « esso, potrà
eventualmente servire a tutt'altra dedizione ». La figura del mio
monumento «tende le braccia e guarda verso il mare e non verso la
montagna. I frammenti architettonici che ne formano la base sono copiati
da quelli esistenti a S. Giusto e al Museo Lapidario. Che volete di più?
Basterà togliervi l'aquila, e avrete il vostro monumento bell'e pronto.
» Il Rendic era amicissimo di Riccardo Zampieri: ambidue, poi, esponenti
di due irredentismi di diversa tendenza ma che si trovavano di fronte a
un oppressore comune. Andavano perfettamente d'accordo fino al punto di
cooperare a un'intesa atta a creare rapporti di buon vicinato fra le due
nazionalità.

Luigi Conti era scultore ornatista. Il nostro cimitero ha moltissimi bei monumenti usciti dal suo studio. Ebbero favore a quel tempo alcune macchiette triestine in forma di statuette eseguite alla maniera del Barbella. Amicissimo del Garzolini, erano chiamati i due fratelli Siamesi. Giuseppe Garzolini da giovane era stato in Spagna donde aveva portato una collana di paesaggi, eseguiti con nota spiccatamente personale e che furono molto apprezzati segnatamente in Germania. I suoi maggiori quadri si conservano in Spagna. Scrittore forbito, i suoi « Ricordi di Spagna » furono pubblicati dall' Illustrazione Italiana e poi raccolti in volume dal Treves stesso, con illustrazioni di Gustavo Doré. Furono anche tradotti in tedesco. Inoltre pubblicò un volume di « Macchiette campagnole » e altri scritti di natura varia. Al Circolo tenne una « Conferenza contro le conferenze » che allora dilagavano in Italia, ottenendo uno schietto successo.
Francesco Pezzicar,
scultore, era venuto qui giovanissimo da Duino. Stipendiato dal principe
Hohenlohe, aveva studiato prima a Venezia e poi a Roma. Rimase però
sempre nella sua scorza accademica. È sua la statua dello « Schiavo
liberato » che si conserva al Museo Revoltella.
Molti monumenti sepolcrali scolpi per il nostro cimitero.
Eduardo Baldini era uno scultore modesto, ma si era fatto un certo nome
per per alcuni suoi monumenti di tipo perfettamente scolastico. Ambidue
morirono poco dopo costituitosi il Circolo.
Lo scultore Depaul viveva alquanto appartato. Divenne poi insegnante di
scultura alla Scuola Industriale. Di lui ci resta la fontana di Piazza
Garibaldi.

Giuseppe Pogna, già sulla cinquantina, era un'ottima pasta d'uomo. Alto, asciutto e di una magrezza tale che faceva dire allo Scomparini che in lui non esistevano né stomaco né interiora. Da giovane era stato, con suo padre, attrezzista al Teatro Comunale. Poi, vivendo tra artisti, la pittura lo aveva soggiogato. Dopo un breve soggiorno a Venezia, lasciò quell'Accademia. Continuò a farsi da sé. Dipingeva marine. Invece del pennello, adoperava la spatoletta metallica e con quella distendeva i colori sulla tela ottenendo effetti insoliti. Faceva tutto di maniera. Credo che non avesse mai fatto uno studio dal vero. Un giorno andammo in campagna per copiare qualche motivo. Trovato il posto, mi misi al cavalletto a lavorare. Il Pogna si tenne dietro di me. Dopo una oretta mi alzai e volli vedere ciò che aveva fatto l'amico. Possibile?.. Io avevo copiato un albero, lui aveva copiato dal mio quadro lo stesso albero. Dipingeva tele e teloni, senza che nessuno glieli ordinasse. Li teneva nascosti per tema che gli altri artisti gli rubassero i motivi. Era fratello del noto coreografo.

Enea Ballarini si porta a meraviglia
ancor oggi. Venuto qui giovanissimo da Bologna, divenne poi
triestinissimo. Vantava la sua città natia in maniera paradossale. Una
volta assicurò che colà gli zamponi avevano la lunghezza di un metro. Un
nugolo di improperi lo fece tacere. Egli non voleva darla vinta e
scommise che ne avrebbe fatto venire un esemplare. Grande attesa. Il
pacco arrivò, la cena era fissata per quella sera. Lo zampone doveva
esser visto solo a tavola. Antipasto, risotto, ciarle, frizzi... Si fece
largo dalla cucina un tavolo lungo con una cosa nascosta da un pannolino
bianco. Aveva l'aspetto macabro. Qualcuno tirò il panno; si scorse di
sotto lo zampone, la cui cotenna era cucita in quattro punti. Era
proprio lungo un metro. Aveva vinto lui !
Giuseppe Barison non era uomo da perdere il suo tempo in ciarle al
Caffè. Faceva solo di tanto in tanto una visitina ai colleghi ma senza
sedersi al tavolo. Era sempre stato un po' scontroso, aspro e
brontolone, ma, sapendolo prendere, riusciva malleabile, sia pure a modo
suo. Era onesto fino allo scrupolo e cosi nella sua arte di cui aveva al
suo attivo molte belle cose e molti bei successi. Nel 1887 espose alla
mostra di Brera la sua « Pescheria » e con questo quadro concorse al
premio « Principe Umberto » di 4000 lire. Secondo la giuria, un solo
concorrente stava a contendergli il premio: lo scultore Urbano Nono. Il
Barison fu bocciato perché suddito austriaco.
Il seguente aneddoto varrà a tratteggiare meglio il suo temperamento. Un giorno fu pregato da una gentile signora di farle visita per vedere alcuni quadri che essa aveva eseguito e sui quali desiderava di udire il suo giudizio. Il Barison si recò da lei all'ora stabilita. La signora aveva già posto in buona luce le tele che il pittore esaminò ad una ad una. Richiesto del suo parere, mise tempo a rispondere, infine si decise e sentenziò: A casa propria ognuno è padrone di far ciò che vuole.
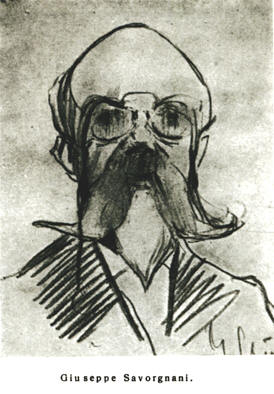

Giuseppe e Carlo
Savorgnani, padre e figlio, due egregi artisti pittori ornamentisti.
Il vecchio era già allora vecchione: mustacchi e pizzo alla Vittorio
Emanuele. Ogni domenica il suo coperto lo attendeva alla tavola del
Caprin. Era ricercatissimo maestro di disegno. Di sera, per ore e ore al
Caffè, a fare disquisizioni d'arte, di quelle che non concludono e con
cui si ritorna al punto di partenza, oppure a mangiarsi quintali di
giornali. Suo figlio Carlo, capacissimo nel suo mestiere, lasciava
uscire dalla "cantina" del suo petto un vocione che dal tono pareva
volesse mangiare il suo interlocutore.
Icilio Turri, già in quel tempo aveva preso dimora tra noi. È sempre
apprezzatissimo architetto al nostro Comune. La sua parlata toscana, che
faceva uno strano contrasto col nostro dialetto, gli cagionò qualche
sorpresa che non si sarebbe aspettata. Così quella volta in cui, dopo un
sopraluogo fatto in un esercizio di Roiano, la persona indiziata andò a
lagnarsi al nostro Ufficio Edile perché teneva dei dipendenti che non
conoscevano neppure l'italiano.
Povero Turri! Ora la sua parlata non è pura di certo e farebbe rizzare i
capelli a un cittadino di Borgo Ognissanti. Achille Borgo Caratti,
paesista, ebbe anni di gran voga. Dipingeva delle tempere con un'abilità
straordinaria: erano per lo più vedute dei laghi lombardi.
Enrico Levi, giovane scultore, era capace di passare giornate intere al Caffè, se l'ispirazione che aspettava non si decideva a comparire. Allora esercitava la sua lingua, che aveva certo delle affinità con quella del formichiere. Ogni qual volta passava il cameriere con la fiaschetta del mistrà, si faceva dare qualche schizzatina nel bicchiere. Allora, con abilità tutta sua, sorbiva quella nuvola azzurra lasciando sempre intatta l'acqua. Dopo qualche tempo lasciò la città e si recò nel Brasile, dove rimase una ventina d'anni. Ora vive a Roma.
Dopo gli studi di
Monaco a questa brigata s'erano aggiunti Isidoro Grünhut, Umberto
Veruda, lo scrittore di queste memorie e infine Vittorio Güttner, che si
distingueva da tutti gli altri e in molte cose li distanziava. Tipo
specialissimo di bohémien, zoofilo, era eternamente in bolletta e
bussava a quattrini per interiezioni. « Ma basta, gli si diceva - tu hai
bisogno ancora di dieci fiorini: tutti lo capiscono ». Ma nessuno gli
dava più denari ben sapendo che sarebbero andati a finire dal venditore
di animali. Aveva incominciato con un cane e un gatto. Poi comperò una
civetta, ma era rimasto pieno di tenerezze per uno scimmione che aveva
dovuto lasciare non avendo abbastanza soldi per comperarlo. Lo voleva a
tutti i costi; diceva ch'era un bestione curioso che pareva si fosse
seduto sul blu di Prussia. Con i primi soldi che ebbe, e fu per una
statuina del barone Currò, se lo portò in studio, insieme con un altro
quadrupede che aveva battezzato per una lince, ma che i più dicevano
essere solo un gatto mal riuscito. Il suo studio si trovava in una
casupola adiacente al fondo Ralli che era il Coney Island di Trieste di
quel tempo. Avveniva talvolta che i clienti della giostra bussassero
alla sua porta attirati dallo squittire del pappagallo e dai lamenti
della scimmia. Perché in breve quello studio pareva fosse diventato
1'ambulanza di un veterinario. Appera guarito il cane, fu la volta della
scimmia la quale perdeva a uno a uno i nodi della coda, ridotta ormai a
un moncherino che il Güttner doveva medicare giornalmente. Il puzzo che
ammorbava l'aria faceva scappare i visitatori. Dopo la guerra lo trovai
a Monaco di Baviera, dove aveva preso stabile dimora rimanendo sempre
quello stesso bohémien di una volta. In momenti di crisi artistica,
faceva da cow-boy nei film di tipo americano per il consumo tedesco.
Sono sue le due figure di bronzo che battono le ore sul torrione del
Municipio di Monaco. Da poco erano usciti dall'Accademia di Venezia
Giuseppe Marass, Gustavo Hess e Giovanni Moro, che si dedicarono poi
all'insegnamento. E ancora Giovanni Zangrando e Ugo Balestra. Gustavo
Hess fu segretario del Circolo per un periodo di dodici anni. Diversi
litografi si tenevano sempre uniti alla brigata.
Uno degli inseparabili era anche G. B. Zemba che scriveva poesie e
faceva il critico d'arte per il giornale « L'Alabarda » diretto da
Rienzo Ciatto. Egli era riuscito poi a mettere insieme una biblioteca di
molte migliaia di volumi delle migliori opere, e a lui ricorrevano
sempre gli artisti se avevano bisogno di consultare qualche libro. Un
altro inseparabile tra i non artisti e il più decorativo per forma,
colore, ampiezza e taglio era Giacomo Cumar, il fratello di latte dei
due Siamesi. La fauna marina gli aveva procacciato già a trent'anni una
notevole ricchezza e poteva permettersi di fare anche il mecenate. Con
noi giovani lo scambio avveniva in natura A Veruda e a me egli garantì
il pesce fresco per alcuni mesi in cambio dei nostri lavori.
Nel 1901 fu eletto consigliere comunale. Un bell'umore, che deve certo
aver appartenuto alla Società degli Americani, dettò il suo programma di
attività, e fra altro scrisse: Non mi lascerò mai prendere nelle reti da
quelli che vanno a pescare nel torbido, sgombro di ogni scrupolo. Sarò
d'accordo che si dia una dote al Teatro Verdi purché rappresentino i
Pescatori di Perle. Non ammetterò la Lucrezia Borgia ove si parla di
un pescatore ignobile, che per l'onore della mia casta non posso
ammettere. Non resterò muto come un pesce, ma anche non terrò arringhe.
Combatterò i gamberi (i tedeschi). Mi occuperò della questione
dell'acqua in cui nessuno mi negherà la competenza. Poi si udrà il rombo
della bufera. Balenerà il lampo precursore del tonno. Ma non temete,
lasciate che l'avversario ci guati; cinguetteremo lo stesso come delle
passere e nessuno dirà che per noi non vi è scampo. In alto i nostri
calici di asti-ce augurando che il nostro vessillo trionfi oltre le più
remote contrade dell'As-i-à.
Fedelissimo a questa
compagnia era Antonio Grattoni, capo d'arte dell' Istituto di
Beneficenza. Il ritrovo serale aveva un'altra fisionomia. Oltre agli
artisti più vecchi vi era Giuseppe Caprin. Egli dava il tono alla
radunata e si sapeva sicuro dell'ascendente che esercitava su tutti.
Aveva appena pubblicato il volume I nostri nonni, per il quale
aveva voluto gli facessi il manifesto stradale che fu di alcune figure
in costume del 1830, a colori e di grande formato. Era una cosa nuova,
la quale destò una certa curiosità, perché in quel tempo i manifesti del
genere consistevano per lo più di sola scrittura. Il Caprin che non
aveva mai voluto far parte del Consiglio direttivo del Circolo era però
l'arbitro delle sue sorti, giacché le direzioni non prendevano mai un
deliberato di qualche importanza senza averlo prima consultato. Altro
immancabile era Alfredo Tominz, che dimenticava per un momento i cavalli
vivi e a quel tavolo diventava l'artista.
Saltuariamente compariva Riccardo Pitteri, accompagnato dalla sua ombra,
che era Pietro Vendrame, classico dicitore di versi. Il Pitteri opponeva
altro spirito ai motteggi del Caprin e la giostra s'incrociava, con
grande divertimento della numerosa galleria che non rimaneva soltanto ad
ascoltare.
C'erano il dott. Serravallo, i maestri di musica Giuseppe Sinico e
Antonio Zampieri.

Talvolta anche Pepi
Schollian, il negoziante d'arte, Giacomo Zammattio, quando si trovava a
Trieste, Ernesto Wostry, Giuseppe Janesich, Nico de Amicis, Angelo
Piazza, Carlo Stecher, Paolo Borghi, Della Martina, il professore
Suppancig, Angelo Levi, Luigi Bonetti, tutti assidui frequentatori del
Circolo.
Amicissimo degli artisti era Roberto de Preschern, cugino del Pitteri,
il quale per molti anni fu parte attiva dei Consigli Direttivi del
Circolo e il promotore e curatore di una delle istituzioni più utili già
nei primi anni di vita della Società, cioè del fondo di assistenza per
artisti impoveriti. Dopo breve tempo questo fondo potè disporre di una
somma non indifferente che via via si aumentò, dovuta a elargizioni di
privati. Più di un artista vi trovò sussidio in momenti di difficoltà
materiali. Uno degli animatori, specialmente delle « sabatine », era
Oscar Menzel: lungo, allampanato, sulla quarantina. Aveva incominciato a
studiare medicina come suo fratello, che divenne poi chirurgo primario
al nostro ospedale. Ma, barca stramba com'era, i suoi studi arenarono e
diventò invece più tardi direttore del Monte di Pietà. Era di estesa
cultura. Contrastone, paradossale, caustico, trovava da dire su tutto,
era sempre negativo ed aveva l'abilità nelle discussioni che si facevano
un po' col cervello e sul tardi coi tacchi, di mettere due persone alle
prese, l'uno contro l'altro, a cavarsi gli occhi con gli argomenti
più
assurdi. Infiammabilissimo, quando arrivava alla combustione, non
risparmiava nessuno.
Fu tra il 1891 e il '92, alla sua prima venuta a Trieste, che Isidoro
Grünhut disegnò queste caricature-ritratti di persone di quel tempo, ora
quasi tutte scomparse, che il Circolo ha sempre conservate gelosamente.
Esse furono eseguite come capitava, ma sopra tutto nella sede del
Circolo. In tutti questi disegni egli affermò quella causticità che di
lui faceva un caricaturista classico, un disegnatore superbo. Nel 1893
egli ritornò a Trieste. Veniva da Firenze, dove aveva stabilmente il suo
studio. Si sapeva di già che in quella città s'era fatto strada e un bel
nome ; ma che cosa fosse venuto a fare qui, nessuno lo sapeva, forse
nemmeno lui. Una settimana dopo, di domenica, lo Zemba ricevette un suo
bigliettino sulla cui busta stava scritto: « Urgente ». Poche parole: «
Mi farai un piacere se verrai oggi con me a colazione da Bissaldi.
T'aspetto per il tocco. » Zemba v'andò alquanto in ritardo. Il « Gobbo
», nell'attesa, aveva già inghiottito l'antipasto, la minestra e stava
masticando una bistecca. Lo Zemba si scusò: aveva già pranzato ma gli
avrebbe fatto compagnia. L'altro disse: « Non fa niente, mangerò anche
la tua parte! » Si misero a chiacchierare. Il « Gobbo » finiva il doppio
pranzo. L'altro lo ammirava. Finito che ebbe, accese un sigaro, ordinò
il caffè e si mise comodo. Dopo un po' tirò fuori di tasca una moneta da
dieci centesimi e la mostrò all'amico. « Guarda, » disse « sai cos'è? »
« Si, » rispose l'altro « sono dieci centesimi !» Ebbene, » aggiunse il
« Gobbo » « è tutto ciò che possiedo. Non ho un centesimo di più .. » Lo
Zemba impallidí e l'altro spiegò: « Si, ti ho invitato a colazione
affinché tu pagassi il conto. » Lo Zemba protestò :« Ma almeno potevi
risparmiare il mio pranzo. » Fu tutto inutile; lo Zemba dovette pagare
il conto. Il « Gobbo » aveva preso in affitto una stanza che gli serviva
a doppio uso: da studio e da camera da letto. Gli serviva più per
quest'ultimo, perché vi dormiva di giorno e non lavorava di notte.
Giuseppe Janesich era diventato il suo cassiere e lo incitava al lavoro,
a mettersi sulla buona strada; ma finché questi rimaneva cassiere,
l'altro trovava ch'era meglio rimandare al più tardi possibile un
radicale cambiamento di vita. Viceversa trovava gusto a seminare a
destra e a sinistra ritrattini a matita e caricature. Fu in quel tempo
ch'egli decorò quel famoso barilotto, che tutti gli anni, pieno di vino,
faceva la sua comparsa al Circolo nel giorno di S. Giuseppe, per
festeggiare i tre Pepi della nostra compagnia: Giuseppe Janesich, che
aveva istituito la festività, Giuseppe Pogna e Giuseppe Marass. Riuscì
un piccolo capolavoro. Durante il primo S. Giuseppe fu festeggiato
l'artista e furono festeggiati i tre Pepi, ma il contenuto del barilotto
tradì molte teste e molte gambe. Chi se ne accorse maggiormente in una
successiva ricorrenza, fu Eusebio Curelli che, dopo quell'assaggio,
voleva a tutti i costi portare il piano del Circolo in testa al molo S.
Carlo per tenervi un concerto. Fu bravo il custode a distoglierlo.

Isidoro Grünhut ebbe poi l' incarico di eseguire ritratti dei figliuoli
di Vittorio Salem:
Enrico Paolo, oggi nostro podestà, e Lilly Bozza-Salem. Roberto de
Preschern, per agevolargli il compito, gli mise a disposizione una
stanza del suo lussuoso appartamento. Il « Gobbo » ne fu contentissimo,
ma a ritratti finiti l'amico ebbe bisogno di una settimana per far
pulizia. Ogni cosa era imbrattata di colore. Puliva i pennelli sul
rovescio del tappeto persiano che si trovava nella stanza. Una signora
gli prestò un suo costoso vestito perché lo copiasse, ma pare che la
modella che doveva indossarlo fosse più voluminosa. Per farvela entrare,
lo aperse con un taglio nella schiena come uno stoccafisso, poi glielo
rimandò così con tanti ringraziamenti.
Pigliati i denari dei ritratti, se la spassò.

Uno dei suoi intimi era
Carlo Coronini, la viola del quartetto Heller, che in quel tempo teneva
cattedra di buona musica a Trieste. Giulio Heller, d'origine polacca,
era primo violino, Alberto Castelli secondo e il Piacezzi violoncello.
Alberto Castelli istruì poi il nostro quartetto Jancovich.
Il « Gobbo » rimase ben presto senza un soldo, ma prevedendo
questo vuoto di cassa aveva già mandato cinquanta lire a qualcuno a
Firenze perché ritirasse dal Monte di Pietà alcuni suoi indumenti. Un
giorno comparve in pelliccia e in tuba Faceva tanto caldo da poter
uscire in giacca!
La pelliccia esternamente non era tanto unta: trent'anni prima doveva
essere stata messa la prima volta! La teneva sempre chiusa e
abbottonata, tanto da sbuffarci dentro. Un giorno, non so quale
indiscreto volle vedere di che pelo fosse foderata internamente. Il «
Gobbo » fu colto di sorpresa. Fu una risata generale: non vi erano più
che poche tracce di pelo e solo in quelle parti non intaccate dai
movimenti usuali. Pareva uno scendiletto di albergo di quart'ordine! Il
giorno dopo capì che era inutile insistere su quell' indumento: lo buttò
sotto il tavolo a far da tappeto. Egli frequentava, come tutti gli
altri, il Caffè Chiozza. Una volta vedemmo prendere posto ad un tavolo
vicino un coso grosso e tarchiato. Nessuno vi badò più che tanto. « Il
Gobbo » era più indiavolato del solito: non aveva visto il nuovo venuto
perché gli voltava la schiena. Era un uomo sulla trentina e vestiva alla
foggia dei Toscani della campagna. Teneva in mano un bastone
esageratamente grosso e nodoso. Ad un tratto pestò impazientemente il
pavimento col suo randello per chiamare il cameriere che ritardava di
portargli il mocca. A quel rumore il « Gobbo » si voltò. Rimase
pietrificato! Il suo viso divenne bianco, rosso, paonazzo. Non sapeva
che fare: scappare non poteva, sparire era impossibile. Si fece ancor
più piccolo di quello che era; nessuno ne capiva la ragione. Il "coso"
sorbi il caffè, pestò ancora col bastone e pagò. Si alzò e s'avvicinò al
« Gobbo », gli batté sulla spalla e lo invitò a passare con lui in un
altro canto del Caffè. Questi si alzò e, mogio mogio, lo segui. I due
discorsero, o per meglio dire, il «Gobbo» stava zitto e l'altro parlava
concitatamente e con gesti poco rassicuranti per il nostro amico. L'
intervista durò poco. Il forestiere se ne andò e il « Gobbo » ritornò al
suo posto. Si rimise un po' e raccontò che quel tale veniva da una
cittadina della Toscana. Aveva una sorella che viveva a Firenze presso
una zia.
Egli, il Grünhut, la aveva conosciuta, anzi aveva commesso con lei
qualche irregolarità che suo fratello voleva fosse chiarita dal sindaco.
« La settimana scorsa », continuò « egli mi mandò un telegramma di una
sola parola: « Aspettiamo »; io risposi « Aspettate »; invece non ha
aspettato niente ed è venuto lui in persona. Dice che rimarrà qui fin
tanto che io non abbia regolato quella pendenza. Come faccio ora a
cavarmela?. Ma ridiventò padrone di sé, si mise a ridere e non ci pensò
più.
L' indomani andò al Caffè. Il "Coso" era già al suo posto, bevette il
caffè, col bastone pestò il pavimento, pagò e se ne andò con un'occhiata
al « Gobbo » da mangiarlo vivo. Il terzo giorno la stessa cosa, e cosi
di seguito; poi nessuno vi abbadò più. Un giorno comparve col «Gobbo»,
stesso. Questi ce lo presentò: era di poche parole e gentile soltanto
quel poco che basta per non essere incivile. Si occupava poco dei fatti
nostri, diceva solo si e no pestando per terra col randello. Memento per
il « Gobbo »! Ma poi questa abitudine di pestare era divenuta una
ossessione e rompeva le scatole a tutti. « Ma spediscilo in Toscana!» si
diceva al «Gobbo». Magari, rispondeva « trovatemi lo speditore e ve lo
dò per niente ».
Poi si capi che qualche cosa stava maturando. Un giorno il « Coso »
sparì e rimase assente alcun tempo. Ricomparve con una signorina: era la
sorella! Due giorni dopo ebbe luogo il matrimonio civile al Consolato d'
Italia.
Il «Gobbo» raccontò poi che alla domanda rituale che gli fu rivolta, se
era contento di prender moglie, al suo « si » , obbligatorio avrebbe
volentieri aggiunto un bemolle, ma sapeva che non avrebbe servito a
nulla e cosi se lo tenne in cuor suo.
Subito dopo la cerimonia la moglie riparti per la Toscana. Egli, uscendo
dal Consolato, incontrò lo Zemba e fecero un po' di strada insieme. A
uno svolto si imbatterono in un venditore di caramei. Il «Gobbo» tirò
fuori di tasca due soldi, ne comperò uno e lo porse a Zemba. « To' »,
gli disse « sono i miei confetti di nozze »! Alle tre era con noi a fare
la partita di bocce. Rimase ancora un poco di tempo a Trieste e il
Janesich era sempre più o meno il suo cassiere. Non si decideva mai a
partire e si sapeva che molti lavori lo aspettavano a Firenze.
Ora stava facendo un ritratto di certo Salom, ma a farlo lavorare ci
volevano gli argani. Una sera il Janesich lo mise con le spalle al muro.
« Quante sedute ti occorrono ancora per finire quel ritratto? » gli
domandò. « Ma che sedute! » rispose il « Gobbo » « In un'ora di lavoro
sarebbe terminato. » « Ah, cosí ! » rispose l'altro « Benissimo!» Ci
mettemmo d'accordo tutti. Uno avverti Salom. Seduta per l' indomani alle
tre da Grünhut. Un altro andò a comperare una vecchia valigia. Un terzo
a prendere la biancheria del «Gobbo» che si trovava dalla lavandaia. Un
quarto comperò un biglietto ferroviario per il diretto delle sei del
giorno dopo per Firenze. L' indomani eravamo tutti puntuali nel suo
studio. Salom capitò all'ora stabilita. Lo mettemmo a sedere mentre Moro
preparava la tavolozza e la consegnava al « Gobbo ». Questi non capiva
la ragione di tutti quegli aiutanti, di tutte quelle visite inattese e
voleva mettersi a cantare, ma lo obbligammo con la forza a star seduto e
a lavorare. Il « Gobbo » vi prese gusto per un po', non vide che in un
canto c'era Moro che metteva assieme dei fagotti di vestiti e biancheria
facendoli entrare nella valigia col ginocchio. Un altro faceva dei
pacchi di altra roba, poi tutti e due sparirono asportando gli oggetti.
Giù attendeva una vettura. Vi misero dentro valigia e fagotti. Al rumore
fatto il « Gobbo » voleva vedere ciò che stava accadendo, ma due robuste
mani lo tennero per le spalle: erano quelle di Janesich... non poteva
neppure voltarsi... Il « Gobbo » rise: « Ma che cosa avete oggi ? Siete
matti ! Dopo un po' volle buttar via pennelli e tavolozza. « Finirò il
ritratto domani », disse. Ma quelle due tenaglie alle spalle lo tennero
inchiodato sulla sedia. Doveva finire il ritratto. Vedendo che non c'era
scampo, lo fini. Salom pagò a Janesich il prezzo convenuto come erano
rimasti d'accordo. Il « Gobbo » poté finalmente alzarsi. Girò gli occhi
intorno: « Dov'é andata tutta la mia roba ? » Cambi di casa stasera, ti
abbiamo preparato una stanza al secondo piano. Ora andiamo tutti a far
la partita. Lo si fece salire in vettura; non vide che la sua roba era a
cassetta bene impaccata. Il cocchiere filò verso la stazione. Il « Gobbo
» ci fece notare che quella non era la strada che conduceva al
«Boschetto». « Ci andremo più tardi », gli rispose qualcuno. Scendemmo.
Il « Gobbo » non aveva ancora compreso.
Infine ci dirigemmo verso la vettura diretta per Firenze. Fu appena
allora che Grünhut capi che facevamo sul serio. Lo si fece salire in
vettura e si chiuse lo sportello. Attraverso il finestrino Janesich gli
passò il biglietto ferroviario, poi l'ammontare pattuito col Salom per
il suo ritratto e un pacchettino di commestibili per il viaggio. La
macchina fischiò... Addio ! Addio !
Povero « Gobbo » ! Io
non lo vidi più. Mori due anni dopo. Soffriva di una malattia di cuore e
terminò la sua vita sregolata in un ospedale di Firenze. I suoi
strapazzi lo finirono a trentun anni, un anno prima del limite che egli
stesso aveva assegnato alla sua esistenza. Ancora giovanissimo, nei suoi
primi anni di studio, scriveva da Monaco lettere di questo tenore al suo
amico Marco Morpurgo : « Ieri notte rincasai molto tardi. Avevo perso
tempo per istrada con un tale mai visto che voleva a tutti i costi che
avessi perduto un cavastivali. Entrato nella mia stanza, la trovai
ingombra di bauli e di una cappelliera. Subodoro subito lo sfratto. Per
sfogarmi apro la cappelliera e ne estraggo un cappello a cilindro alto
un cubito. Poi prendo un pezzo di pastello nero e lo passo ripetutamente
sulla pelle interna del copricapo. « Tu sei ben servito, mio caro
successore. » Vado a dormire. L' indomani alle dieci mi sveglia la
padrona: « Signor Grünhnt, la sua stanza è affittata e deve andarsene. »
Ciò che dissi, non so, ma dissi molto. Mi calmò l'idea che le dovevo
ancora nove marchi. Dunque erano nove marchi guadagnati. Nel pomeriggio
ripasso per prender la mia roba. « La sua roba la trattengo fino che non
mi paga i nove marchi.» « Ah cagna, ti chiamerò in tribunale e pagherai
anche le spese del processo e intanto la fronte tigrata l'avrà quell'
innocente che ha preso la mia stanza. »
Poi in un'altra successiva : « Ieri abbandonai l'ospedale e, non faccio
per vantarmi, ma era una bellissima giornata. Giunto a casa credevo di
trovare il mio amico Variano, col quale divido la stanza, ma non c'era.
Come si fa ? Io avevo bisogno di trovarlo perché ero privo di quei mezzi
materiali che abitano nel taccuino. Aspetto, ma l'amico non capita.
Stufo di aspettare, volevo recarmi all'ufficio anagrafico per domandare
il suo indirizzo, quando egli ansante si precipita nella stanza, ma
ahimé ! purtroppo ahimé ! senza un soldo in scarsè. »
« Scusa questo gallicismo e non è il solo usato dai nostri poeti per
rovinare la nostra lingua. »
Ma non è da dire che il Grünhut fosse composto solo della pasta degli
scioperoni e degli scapigliati, per non dire degli scapestrati. Aveva le
sue tristezze, gli scoramenti, i momenti di serietà. Egli si confidava
allora con lo Zemba. « So » gli scriveva « di essere stravagante e sopra
tutto sregolato. Ma, che vuoi ! so anche di essere condannato a morire
giovane e ho la convinzione che non arriverò ai trentadue anni. Con la
mia malattia non si campa a lungo. » Questo incubo lo opprimeva, lo
ossessionava e cercava di sottrarvisi col condurre una vita spensierata
più che poteva per godersi quel poco di vita che gli rimaneva ancora. «
In una prossima mia ti racconterò le mie scappattelle perché, per quanto
abbia tentato di diventare una persona a modo, non ci riesco ancora.
Però presto mi metterò al lavoro per concorrere a un premio di lire 5000
istituito a Bologna per un quadro di soggetto stabilito. Se lo vinco,
vengo ad abbracciarti e ti fo prendere la sbornia per tre settimane di
seguito. » Poi in una lettera successiva : « Ti rallegri del mio
trionfo, della mia soddisfazione artistica ! lo appresi la cosa soltanto
dai giornali triestini, i quali si affrettarono a preannunciare il
risultato del concorso in base alle critiche favorevolissime dei
giornali bolognesi e milanesi. Di fatti questi giornali ponevano il mio
lavoro in testa a tutti gli altri. Ma poi la Commissione esaminatrice
trovò che io non ero cittadino italiano e o ha pensato bene di mandare a
vuoto il concorso. A ogni modo la mia soddisfazione è già grande, «
sapendo di aver concorso senza alcuna pretesa e anzi di mala voglia.
Quindi il risultato ha superato la mia ambizione.
Ma poi il suo
temperamento lo portava alla solita leggerezza. In testa ad un'altra
lettera, sempre allo Zemba, da Roma, aveva disegnato la pianta del
quartiere dove stava di casa e dove aveva lo studio. Casa e studio erano
discosti forse un quarto d'ora di cammino l'uno dall'altro e il percorso
sulla carta era segnato con delle crocette rosse. Con dei punti rossi
aveva poi tracciato un altro percorso, sempre fra gli stessi luoghi ma
molto più ampio e lungo. « Caro Zemba, » scriveva « tu sei troppo poco
intelligente per capire che mistero si nasconda in questo schizzo
topografico marcato da croci e puntini. Te lo spiego: la fila di
crocette rosse ha per capo da una parte la mia casa, dall'altra il mio
studio. In passato impiegavo circa un quarto d'ora per andare da un
posto all'altro. Ora devo seguire il cammino dei puntini per andare da
casa allo studio e impiegare tre quarti d'ora. Quel tracciato di croci
ha poi un significato ancora più terribile. Là si trovano il tabaccaio,
la lavandaia, il calzolaio, il droghiere, il salumaio, il sarte, il
cappellaio e varii osti. Mandami qualche soldo onde possa cancellare
qualche crocetta e ridurre il cammino. »
Durante il suo soggiorno a Roma Isidoro Grünhut aveva conosciuto il
marchese della Stufa, del quale fece poi uno splendido ritratto. Il
marchese ne fu tanto entusiasta da indurre il Grünhut a prendere dimora
a Firenze. Egli lo introdusse nelle principali famiglie e il pittore
esegui buon numero di ritratti che sono le sue opere migliori. Era
ricercatissimo.
Se avesse avuto giudizio, e sopra tutto salute, avrebbe potuto
guadagnarsi una fortuna. Il marchese gli aveva assegnato uno studio nel
suo palazzo, ma alla sua morte, avvenuta qualche anno prima di quella
del Grünhut, gli eredi non misero tempo in mezzo a far sloggiare il
pittore.
***
Edizioni Italo Svevo. Trieste, ottobre 1991